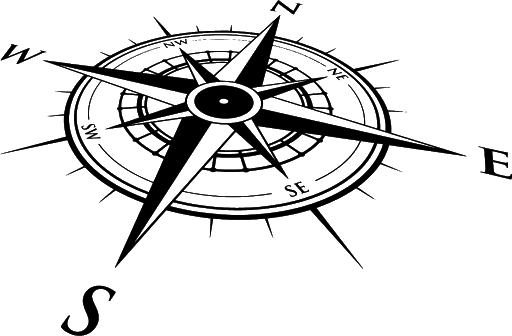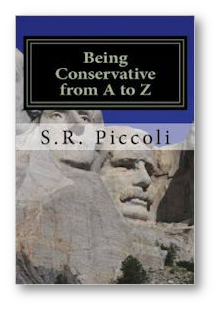| CARVIEW |
rosadeiventi
Non solo geopolitica: perché stare dalla parte del popolo iraniano

Mio pezzo su NicolaPorro.it/Atlantico. Una mia riflessione sul tema del giorno, senza sottovalutare i rischi e gli interessi geopolitici in gioco, ma tenendo nella debita considerazione anche gli aspetti etici, ideali e umanitari.
In Iran è un inferno, un mattatoio, con migliaia di corpi senza vita accatastati lungo le strade. Scene inenarrabili che giungono a noi malgrado il black out di Internet imposto dai macellai del regime degli ayatollah.
La partita geopolitica
C’è una tentazione ricorrente, quando da noi in Occidente si parla dell’Iran, che consiste nel ridurre tutto a una partita di scacchi regionale: Israele contro gli ayatollah, Netanyahu contro Teheran, la solita guerra a bassa intensità combattuta per procura. È una tentazione comprensibile ma, quantomeno nel caso specifico, profondamente fuorviante.
Che il governo israeliano abbia un interesse strategico nel crollo della Repubblica Islamica è un dato di fatto, non una rivelazione. Che per le strade di Teheran siano in azione apparati israeliani sotto mentite spoglie è un fatto noto e ammesso da più parti. Ma fermarsi a questi dati di fatto significa adottare lo sguardo dei governi e delle cancellerie, non quello della realtà iraniana.
Crisi di legittimità
Perché la crisi che attraversa oggi l’Iran non nasce a Tel Aviv, né a Washington: nasce nelle sue città, nelle sue università, nelle sue famiglie, in un conflitto sempre più aperto tra il regime e la società che pretende di governare.
Da anni, e con un’accelerazione evidente nell’ultimo biennio, la Repubblica Islamica vive una frattura strutturale con la propria popolazione. Le proteste non sono un fenomeno episodico né il prodotto di agitazioni eterodirette dall’estero, come sostiene la propaganda ufficiale, ma l’espressione ricorrente di una crisi di legittimità profonda.
Arresti arbitrari, repressione violenta delle manifestazioni, condanne capitali, blackout informativi e persecuzione sistematica di attivisti, giornalisti e minoranze hanno accompagnato ogni ondata di dissenso. Organizzazioni internazionali per i diritti umani e osservatori indipendenti concordano su un punto essenziale: lo Stato iraniano non si limita a governare in modo autoritario, ma considera una parte crescente della propria società come un nemico interno da neutralizzare. È su questo terreno, prima che su quello geopolitico, che si gioca la partita iraniana.
Ipocrisia dell’Occidente
Ed è proprio qui che l’Occidente mostra tutta la sua ambiguità, quando non la sua ipocrisia. Di fronte a un regime che reprime, uccide e terrorizza una parte consistente della propria popolazione, le capitali europee continuano a rifugiarsi in un linguaggio burocratico fatto di “preoccupazione”, “monitoraggio” e “inviti alla moderazione”.
Una neutralità apparente che, nei fatti, finisce sempre per avvantaggiare chi detiene il potere e non chi lo subisce. Perché tra uno Stato armato fino ai denti e cittadini disarmati che scendono in piazza, l’equidistanza non è equilibrio: è rinuncia a giudicare.
Le piazze iraniane non chiedono interventi militari stranieri né invocano governi fantoccio imposti dall’esterno. Chiedono, in modo ostinato e sempre più disperato, ciò che il regime nega da decenni: libertà personali, dignità civile, fine della repressione. A guidare la protesta sono soprattutto giovani e donne, ma il dissenso attraversa classi sociali, territori e generazioni. È una mobilitazione che nasce dal basso e che parla un linguaggio universale, non ideologico.
Ridurla a una manovra orchestrata da potenze straniere, o anche soltanto strizzare l’occhio a tesi minimaliste di questa fatta, significa fare il gioco degli ayatollah e negare agli iraniani persino la titolarità della propria rivolta.
Sostenere il popolo iraniano non significa sposare l’agenda di Israele, degli Stati Uniti o di qualsiasi altro attore regionale. Significa, molto più semplicemente, riconoscere che esiste una linea di demarcazione netta tra un regime teocratico che governa attraverso la paura e una società che chiede diritti fondamentali.
Confondere le due cose, o fingere che siano inseparabili, è una comoda scorciatoia per non prendere posizione. Ma è anche il modo più sicuro per tradire quei valori che l’Occidente continua a proclamare come universali.
Il conto della storia
Ad un certo punto, la storia presenta il conto. E costringe a scegliere. Non tra Israele e Iran, non tra Oriente e Occidente, non tra stabilità e caos, ma tra un regime che governa attraverso la violenza e un popolo che chiede di vivere libero. Tutto il resto – la diplomazia attendista, le analisi prudenti, le equidistanze di comodo – è solo un modo elegante per rimandare una decisione che è prima di tutto morale.
Schierarsi con il popolo iraniano non significa invocare guerre, né benedire cambi di regime eterodiretti. Significa smettere di fingere che la repressione sia una “questione interna”, che la teocrazia degli ayatollah sia un interlocutore come gli altri, che la stabilità valga più della vita e della dignità di milioni di persone. Significa riconoscere che esistono regimi con cui non si può essere neutrali senza diventare complici.
L’Iran di oggi è una prova di verità anche per l’Occidente. Se davanti a un mattatoio umano ci rifugiamo ancora una volta nel linguaggio delle cancellerie, allora il problema non sono solo gli ayatollah. È l’idea stessa di valori universali che abbiamo smesso di difendere quando hanno smesso di essere convenienti.
Quando vedere non è più sufficiente: Mantegna e lo sguardo silenzioso dei Magi
Una meditazione sulla fede, la visione e i limiti dello sguardo umano *
C’è un momento, davanti a un grande dipinto, in cui il tempo sembra allentare la sua presa. L’Adorazione dei Magi di Andrea Mantegna (1497–1500) crea esattamente un momento di questo tipo. Nulla nella scena è rumoroso o drammatico. I colori sono misurati, i gesti controllati, lo spazio è denso di silenzio. Eppure, più a lungo si osserva il dipinto, più esso sembra sottrarsi a un’interpretazione immediata.
I Magi sono arrivati. Sono giunti alla fine di un lungo viaggio. Si inginocchiano, si inchinano, offrono i loro doni. Tutto sembra essere al suo posto — tranne un dettaglio, discreto ma perturbante. I loro occhi non incontrano quelli del Bambino. In una scena costruita attorno alla rivelazione, al riconoscimento e all’incontro con il divino, lo scambio di sguardi che ci aspetteremmo semplicemente non avviene.
È in questa assenza, in ciò che non viene mostrato, che Mantegna ci invita a fermarci — e a riflettere su che cosa significhi davvero vedere.
Nella maggior parte delle rappresentazioni tradizionali dell’Adorazione, è la visione a strutturare l’intera composizione. Le linee degli sguardi convergono verso il Cristo infante, guidando l’occhio dello spettatore e confermando il momento del riconoscimento. Guardare equivale a credere. Mantegna rompe deliberatamente questa logica visiva. I Magi sono fisicamente vicini al Bambino, umilmente posti davanti a Lui, eppure i loro sguardi si abbassano o si distolgono. L’atto del vedere, così centrale nella pittura rinascimentale, viene negato proprio nel momento in cui sembrerebbe più necessario.
Non è un incidente compositivo. È la chiave del dipinto.
I Magi non sono raffigurati come figure distratte o incerte. Sono sapienti, astronomi, interpreti di segni. Il loro viaggio non ha avuto inizio con una visione, ma con una comprensione: una stella osservata, un significato decifrato, una verità intuita più che rivelata. Molto prima di giungere a Betlemme, avevano già riconosciuto chi fosse quel Bambino. Il loro arrivo non è una scoperta, ma una conferma.
Ora, posti davanti all’Incarnazione stessa, la vista si rivela insufficiente. Il mistero divino non può essere posseduto dallo sguardo. Fissarlo implicherebbe padronanza, comprensione, persino controllo. I Magi, invece, abbassano gli occhi. La curiosità lascia il posto alla reverenza. Il corpo si inchina là dove lo sguardo si ritrae.
In questo gesto silenzioso, Mantegna articola un’intuizione teologica profonda: Dio, anche quando è pienamente presente in forma umana, resta in ultima istanza invisibile. Il Bambino può essere visto come corpo, ma non afferrato come mistero. Gli occhi distolti dei Magi riconoscono i limiti della percezione umana. Essi sanno che ciò che conta davvero non può essere catturato dalla sola visione.
In questa scelta risuona anche una forte eco della cultura classica. Mantegna, profondamente immerso nell’arte e nel pensiero dell’antichità, attinge a un linguaggio visivo più antico del cristianesimo stesso. Nel mondo classico, il divino viene spesso avvicinato indirettamente. Gli dèi sono onorati attraverso la postura, la misura, il silenzio, più che mediante un confronto diretto. Abbassare lo sguardo significa riconoscere un ordine superiore. Qui i Magi — re stranieri e uomini di sapere — si comportano come antichi adoranti davanti a qualcosa che li trascende.
Eppure, forse l’aspetto più radicale del dipinto non risiede tanto nelle figure rappresentate, quanto in ciò che l’opera chiede a noi.
Rifiutandosi di lasciare che siano i Magi a guidare i nostri occhi, Mantegna trasferisce la responsabilità allo spettatore. Se loro non guardano il Bambino, dobbiamo farlo noi. Il percorso visivo non resta più chiuso all’interno del dipinto; si estende verso l’esterno, verso chi osserva. Non siamo più spettatori passivi che seguono traiettorie prestabilite. Diventiamo partecipi, coinvolti direttamente nell’atto della contemplazione.
In questo senso, l’Adorazione dei Magi funziona meno come un’illustrazione narrativa e più come una meditazione. Non istruisce; invita. Il silenzio dello sguardo dei Magi apre un silenzio dentro lo spettatore. Restiamo soli davanti al Bambino, senza intermediari, senza certezze visive, senza rassicurazioni.
Ed è forse questa l’intuizione più profonda di Mantegna. La fede non nasce dallo spettacolo. Non prende forma da ciò che abbaglia gli occhi, ma da ciò che interroga la mente e acquieta il cuore. I Magi hanno già compiuto il loro viaggio. Hanno visto il segno, lo hanno seguito e lo hanno compreso.
Ora, davanti al mistero stesso, si inginocchiano.
Nell’Adorazione dei Magi, Andrea Mantegna non ci mostra figure che non riescono a vedere Cristo. Ci mostra figure che hanno visto abbastanza — e che comprendono come, a un certo punto, il vedere debba lasciare spazio alla reverenza.
Sorry, il più importante alleato degli Usa in Medio Oriente non è Israele
ABSTRACT: Israele è davvero il principale alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente, o questa definizione regge solo sul piano della retorica?
In questo articolo per InsideOver analizzo una domanda posta da Tucker Carlson che mette in luce una contraddizione centrale della politica estera americana: la distanza crescente tra alleanze dichiarate e dipendenze operative. Israele resta il partner più visibile e simbolico di Washington, ma è il Qatar a svolgere un ruolo sempre più decisivo sul piano pratico, ospitando infrastrutture militari chiave e fungendo da interlocutore con attori che gli Stati Uniti non possono affrontare direttamente.
Il confronto non è morale, ma geopolitico. Rivela una strategia americana sempre più fondata sulla necessità e sull’emergenza, più che su una visione coerente di lungo periodo. Ne emerge un quadro segnato da ambiguità, costi reputazionali e difficoltà nel definire cosa significhi oggi essere un “alleato”.
Un tema cruciale per capire il presente — e il futuro — della proiezione americana in Medio Oriente.
Mio pezzo su InsideOver
Perché Firenze manda in tilt la logica della performance

Mio pezzo su Money.it
ABSTRACT: La mostra dedicata al Beato Angelico a Palazzo Strozzi non è una di quelle esposizioni che cercano l’effetto spettacolare. Non aggredisce lo sguardo, non punta sul colpo di scena. Fa qualcosa di più sottile — e, proprio per questo, più destabilizzante.
In questo articolo racconto la mia esperienza personale a Firenze, tra la visita agli Uffizi e soprattutto l’incontro ravvicinato con l’opera del Beato Angelico. Un artista che pensavo di conoscere bene, e che invece, visto in questa forma concentrata, ha prodotto un vero punto di rottura percettivo. Non uno choc improvviso, ma una progressiva perdita di distanza critica: la sensazione che la bellezza, quando è troppa e troppo coerente, smetta di essere “gestibile”.
Solo a posteriori viene spontaneo collegare questa esperienza a ciò che da tempo si associa a Firenze, la cosiddetta sindrome di Stendhal. Ma il cuore del racconto non è l’etichetta. È l’effetto concreto di un’esposizione che chiede tempo, attenzione e disponibilità a rallentare.
Per una testata come Money.it, orientata alla realtà e alle scelte razionali, questa mostra offre una lezione molto pratica: non tutto ciò che conta è ottimizzabile. Esporsi deliberatamente a una bellezza che non serve a nulla, se non a cambiare il nostro sguardo, è un investimento sul capitale mentale ed emotivo.
Un invito, quindi, a visitare la mostra non per “vederla tutta”, ma per lasciarle fare il suo lavoro. Anche a costo di uscirne un po’ disorientati.
Il Presidente e la Madonna

ABSTRACT: L’8 dicembre scorso, mentre visitavo a Firenze Palazzo Strozzi e ammiravo le Madonne di Beato Angelico, ho ricevuto la notizia di un fatto inedito nella storia americana: Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha pubblicato un messaggio ufficiale per la Solennità dell’Immacolata Concezione, rendendo omaggio pubblico alla Vergine Maria. Un gesto senza precedenti: nessun presidente americano, nemmeno cattolico, aveva mai espresso un riconoscimento così esplicito alla Madonna in occasione di questa festa.
Il messaggio di Trump, protestante sostenuto in larga parte da ambienti evangelici, ha un tono solenne e commosso, che sembra sfiorare la devozione cattolica con rispetto e riconoscimento. Non è un atto politico, né di marketing: la conclusione, con la preghiera mariana, lo colloca nel solco di una tradizione spirituale che attraversa i secoli.
Eppure, quasi nessuno ne ha parlato. La stampa americana, europea e italiana ha ignorato l’evento, eccetto testate religiose molto specializzate. Colpisce in particolare il silenzio di Avvenire, il quotidiano della CEI, che non ha finora dedicato un articolo a un fatto così unico.
Nel mio articolo per InsideOver, racconto questo gesto storico, la sua solennità, e la suggestione personale che nasce dall’incontro tra la devozione di Beato Angelico e un presidente che per la prima volta, pubblicamente, si rivolge alla Madonna.
Mio pezzo su InsideOver
La nuova Strategia USA decisa da Trump, spiegata bene

ABSTRACT: Il mio articolo pubblicato oggi su Money.it analizza la nuova Strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti e il suo impatto sull’Europa. Il documento, firmato dal presidente Trump e diffuso dalla Casa Bianca, segna un cambio di paradigma nella politica estera americana, ponendo al centro l’Emisfero Occidentale e rilanciando la tradizionale Dottrina Monroe. Secondo Washington, gli Stati Uniti devono tornare “preminenti” nel loro emisfero come condizione per sicurezza e prosperità, mentre le risorse diplomatiche e militari non possono più disperdersi globalmente.
L’Europa è percepita come un alleato importante, ma anche come un continente in declino. Il documento parla di «reale e stridente prospettiva di cancellazione della civiltà», collegando fattori culturali, demografici e politici. Migrazione, censura delle opinioni, perdita di sovranità e natalità ai minimi sono considerati rischi sistemici, capaci di minare anche la coesione della NATO nei prossimi decenni. Per gli Stati Uniti, la priorità è aiutare l’Europa a “raddrizzare la traiettoria”, ma chiedendo in cambio più difesa, sicurezza dei confini e realismo strategico.
Un capitolo centrale riguarda la guerra in Ucraina: l’obiettivo indicato dalla NSS è «negoziare una rapida cessazione delle ostilità» per stabilizzare l’economia europea ed evitare un’escalation che indebolirebbe l’Occidente. Il documento non è anti-europeo, ma avverte che l’America non può più occuparsi di tutto il mondo: gli alleati devono assumersi maggiori responsabilità. Per l’Italia e per l’UE si apre una fase di scelte strategiche inevitabili, con implicazioni economiche, politiche e culturali di lungo periodo.
Mio pezzo su Money.it
La Francia e il dibattito sulle radici cristiane d’Europa

Con questo mio nuovo articolo inauguro la mia collaborazione con InsideOver, e ho scelto di farlo affrontando una domanda che considero decisiva per comprendere il presente europeo: che cosa resta dell’Europa quando si recidono le sue radici cristiane?
È una domanda che torna ciclicamente, ma oggi appare più urgente che mai. Negli anni 2002-2003 l’Unione Europea tentò di darsi una Costituzione e decise di non citare la propria eredità cristiana: una scelta motivata da ragioni politiche, ma che rivelava già allora una fragilità culturale profonda. Oggi, dopo vent’anni di secolarizzazione accelerata, crisi identitaria e nuove tensioni sociali, quella fragilità è diventata un vuoto.
Nell’articolo ripercorro quella vicenda e analizzo perché la rimozione delle radici cristiane non sia un dettaglio ideologico, ma un nodo culturale centrale: senza un terreno simbolico comune, le democrazie europee rischiano di trasformarsi in spazi amministrati privi di anima.
Per farlo, dialogo con una costellazione di intellettuali francesi — Zemmour, Delsol, Onfray, Houellebecq, Finkielkraut, Debray — molti dei quali non credenti, ma tutti consapevoli che la civiltà europea è nata dentro una matrice cristiana che ha plasmato diritti, libertà, comunità e la nostra idea stessa di persona.
Non si tratta di chiedere un ritorno alla fede, ma di riconoscere la memoria culturale che ci ha fatti diventare ciò che siamo. Senza questo riconoscimento, l’Europa smette semplicemente di essere Europa. VAI ALL’ARTICOLO.
La lunga guerra civile della destra americana
Mio pezzo su NicolaPorro.it/Atlantico. I media mainstream non ne parlano, ma la destra americana è sconquassata da feroci guerre intestine…
I commentatori politici dei media mainstream italiani non sembrano averlo realizzato più di tanto, ma la destra americana è sconquassata da alcune settimane da feroci diatribe interne che hanno raggiunto lo zenith con alcuni avvenimenti recentissimi.
Antisemitismo di destra
Il primo episodio, onestamente dirompente, risale al 27 ottobre scorso: l’intervista del popolarissimo commentatore politico e podcaster Tucker Carlson a Nick Fuentes, influencer dell’estrema destra americana noto per posizioni apertamente suprematiste e antisemite. Come era da aspettarsi, mezzo Gop e quasi tutti i media di area hanno strigliato severamente l’intervistatore dandogli apertamente dell’antisemita, del provocatore e del traditore.
Un altro episodio, collegato al precedente, è stato la pubblicazione di un video in difesa di Carlson (30 ottobre) da parte di Kevin Roberts, presidente della prestigiosissima Heritage Foundation, con seguito di clamori, dimissioni, sgomento e solenni condanne e incazzature. Il video ha rappresentato per molti uno spartiacque nel dibattito interno al movimento MAGA, con una chiara presa di posizione contro l’accusa di antisemitismo tout court nei confronti di chi avanza critiche alle politiche dello Stato di Israele.
Epstein Files
Un terzo evento di rilievo è stato la stroncatura da parte di Donald Trump di Marjorie Taylor Greene (10 novembre), quando il presidente ha dichiarato che la deputata repubblicana della Georgia “ha perso la rotta” (“she’s lost her way”). Taylor Greene è nota per le sue posizioni “America First” e per essere stata una delle più ferventi alleate di Trump.
In questi mesi però il rapporto tra i due si è guastato, soprattutto sul tema della trasparenza sui documenti di Jeffrey Epstein (Epstein Files). La risposta di della Taylor Greene è stata clamorosa, annunciando in anticipo le sue dimissioni (il 6 gennaio 2026) dal Congresso degli Stati Uniti. “Ho troppo rispetto e dignità per me stessa,” ha dichiarato, “amo troppo la mia famiglia e non voglio che il mio caro distretto debba sopportare una primaria dolorosa e carica d’odio contro di me da parte del presidente per cui abbiamo tutti combattuto… per poi ritrovarmi a combattere e vincere la mia elezione mentre i repubblicani con ogni probabilità perderanno le elezioni di metà mandato…”.
Una silenziosa guerra interna
Questi gli eventi recenti, ma in realtà sono trent’anni che la destra americana combatte una guerra interna silenziosa. Una guerra che non è mai esplosa apertamente, ma che oggi – dopo il terremoto populista e la crisi dell’establishment – mostra linee di demarcazione chiarissime. Non si tratta di una semplice disputa fra correnti: è una trasformazione strutturale del conservatorismo, un conflitto tra due visioni del mondo probabilmente poco compatibili.
Oggi quella guerra è arrivata a un punto di svolta. E la questione di Israele, strettamente connessa al caso Carlson summenzionato ne è la manifestazione più evidente.
Una storia sintetica di questa guerra ha tentato di raccontarla su First Things il direttore di Modern Age: A Conservative Review, Daniel McCarthy, che è anche membro del board di The American Ideas Institute, il think tank conservatore che pubblica The American Conservative, rivista fondata nel 2002 da Pat Buchanan. Cerco di seguire il suo schema per definire a grandi linee le dinamiche principali alla base del conflitto politico e ideale.
I. L’età neocon: quando l’élite decideva per tutti
Negli anni ’90 e nei primi 2000, la destra americana era plasmata da una ristretta élite neoconservatrice. Era questa élite a stabilire cosa fosse “conservatore” e cosa non lo fosse: dalle guerre all’estero al dogma del free trade, dall’euforia globalista alla visione missionaria dell’America come faro democratico planetario.
Il sostegno incondizionato a Israele era parte integrante di questo pacchetto identitario. Non un tema di discussione: un pilastro. Chiunque si scostasse, anche minimamente, veniva bollato come estremista o irresponsabile.
La base conservatrice, intanto, osservava la delocalizzazione delle industrie, la stagnazione salariale e la nascita di un’élite culturale progressista sempre più ostile ai valori tradizionali. Ma le sue preoccupazioni erano trattate come rumore di fondo.
II. La rivolta della base: la crepa si apre
La guerra in Iraq, il 2008, l’implosione della classe operaia bianca e non solo: tutto ciò smonta l’aura di infallibilità dell’establishment repubblicano.
Nascono il Tea Party, i blog ribelli, la critica al “complesso neocon”. La base inizia a capire che i suoi rappresentanti non rappresentano più nulla. E allo stesso tempo si fa strada un nuovo scetticismo: perché l’America dovrebbe sacrificare i suoi giovani, i suoi soldi e i suoi interessi strategici per progetti di ingegneria geopolitica all’estero? L’establishment non ascolta. Reagisce con fastidio e superiorità morale. Ma il vulcano è già sveglio.
III. 2016: l’eruzione – Trump come punto di rottura
L’elezione di Trump non è la causa della rottura: è il prodotto finale della tensione accumulata. Con lui, entra nella destra un blocco nuovo:
• working class;
• ispanici e afroamericani moderati;
• piccoli imprenditori e operai qualificati;
• comunità religiose che non credono più alla globalizzazione progressista.
La nuova destra parla di salari reali, industria, confini, sicurezza urbana, declino sociale. E rifiuta la vecchia retorica interventista. È in questo contesto che Israele diventa la linea del fronte della nuova guerra interna.
IV. Tucker Carlson: il tabù infranto
Per anni, criticare Israele a destra era considerato politicamente suicida. Poi arriva Tucker Carlson, che rompe il tabù: critica alcune scelte politiche israeliane, contesta l’influenza dei suoi sostenitori sulle priorità della destra americana e lo fa non da sinistra, ma da America First.
Per l’establishment, è eresia pura. Per la base populista, è semplicemente logico: “Perché l’America dovrebbe subordinare la sua strategia a quella di qualunque altro Paese?” Il caso Carlson mostra una cosa: la destra non condivide più lo stesso codice morale e geopolitico.
V. Nick Fuentes: la radicalizzazione e la paura dell’élite
Sul versante più radicale dello stesso ecosistema populista si trova Nick Fuentes, che cavalca un’ostilità apertamente dura verso Israele e verso il mondo neoconservatore. È la frangia ultra-populista, giovane, digital-native, iconoclasta. Per l’establishment, è lo spettro della dissoluzione del conservatorismo classico.
Ed è proprio qui che lo scontro diventa tridimensionale:
• l’establishment pro-Israele difende il paradigma del 1990;
• i populisti trumpiani (come Carlson) lo rinegoziano;
• gli ultra-populisti lo rovesciano.
Il risultato è una guerra a tre fronti. Il simbolo perfetto della frattura.
VI. La destra oggi: un equilibrio instabile
La verità è che il trumpismo ha già vinto la guerra culturale – ma non quella organizzativa. I governatori, i senatori di vecchia guardia, i grandi donatori: molti rimangono figli del mondo pre-2016.
La base, invece, è altrove. E quando queste due componenti si scontrano, il Gop diventa ingovernabile. Eppure, anche in questo caos, emerge un filo rosso: la nuova destra è meno ideologica e più produttivista. Vuole il reshoring (rientro in patria di attività produttive che erano state delocalizzate all’estero), salari più alti, controllo delle filiere critiche, un welfare familiare non assistenziale, meno avventure militari e più coesione interna.
È una destra che non esisteva trent’anni fa. È una destra nata dal fallimento dell’élite che pretendeva di parlare a nome di tutti.
Conclusione: la guerra trentennale non è finita — ma il fronte è cambiato
Il caso Israele, con le figure di Carlson e – in versione progressivamente più estrema – Candace Owens e Nick Fuentes, non è un incidente di percorso: è il simbolo della metamorfosi della destra americana. Mostra che il vecchio paradigma non ha più presa, che la base non accetta più dogmi imposti dall’alto e che il conservatorismo sta diventando un movimento complesso, conflittuale, ma anche sorprendentemente dinamico.
La sinistra americana è ingessata nella sua identità culturale. La destra, invece, sta cambiando pelle – anche litigando furiosamente. Da questa guerra trentennale non nascerà la destra di ieri né la destra di oggi, ma la destra che verrà. E capire Israele – il nuovo terreno di battaglia interno – significa capire come la destra americana deciderà il proprio futuro.
Interessante notare che se con Marjorie Taylor Greene, Donald Trump è andato giù con la mannaia, con Tucker Carlson ha avuto un approccio completamente diverso, difendendolo dagli attacchi provenienti dall’ala più convintamente filo-israeliana del Gop, guidata da pezzi da 90 della politica Usa, come il senatore Ted Cruz, e da vari commentatori politici, tra i quali i focosi Mark Levin e Ben Shapiro, co-fondatore della piattaforma The Daily Wire.
“Abbiamo fatto alcune grandi interviste con Tucker Carlson, ma non puoi dirgli chi intervistare”, ha dichiarato Trump ai giornalisti. “Voglio dire, se vuole intervistare Nick Fuentes – non so molto di lui, ma se vuole farlo, che lo faccia, che esca la notizia. Sai, sarà la gente a decidere. Alla fine, è la gente che deve decidere”.
Trump, del resto, si è ben guardato dal commentare le feroci critiche di Carlson a Netanyahu su Gaza. Per non parlare dell’intervento del popolare podcaster al memoriale di Charlie Kirk, allo State Farm Stadium di Glendale, Arizona, il 21 settembre scorso, quando, secondo i più, con un’abile metafora ha lasciato intendere che qualcuno in Israele avrebbe deciso di far fare a Kirk la stessa fine di Gesù duemila anni prima… Ovviamente, da quel momento in poi, dire Carlson vuol dire “il Male” in molti ambienti dentro o vicini a Washington DC e Tel Aviv.
Perché tanti intellettuali stanno tornando a Dio

Il ritorno alla fede tra gli intellettuali e i giovani indica un disagio profondo verso un modello culturale che ha perso potenza normativa. Per l’Europa e per l’Occidente in generale, dove si discute di identità, welfare, natalità e coesione sociale, fenomeni di questo tipo meritano particolare attenzione: forse la religione sta tornando non tanto, o non soltanto, come eredità del passato, ma come risorsa per il futuro. Una bella sfida all’ateismo e all’agnosticismo che sembravano farla da padroni.
Mio pezzo su Money.it
Scie chimiche: prime ammissioni?

Un mito moderno o una verità scomoda sotto i nostri occhi?
Il dibattito sulle “scie chimiche” — quelle linee che solcano il cielo e dividono l’opinione pubblica tra scettici e sospettosi — è uno dei più longevi del nostro tempo. Tucker Carlson lo ha appena riacceso con un’intervista a Dane Wigington, fondatore di GeoEngineeringWatch.org, che accusa i governi di condurre programmi segreti di ingegneria climatica su larga scala.
Carlson non sposa apertamente la tesi, ma le dà spazio: e in un’epoca di fiducia fragile, anche il cielo diventa un terreno politico. Mio pezzo su Money.it
Articoli recenti
- Non solo geopolitica: perché stare dalla parte del popolo iraniano
- Quando vedere non è più sufficiente: Mantegna e lo sguardo silenzioso dei Magi
- Sorry, il più importante alleato degli Usa in Medio Oriente non è Israele
- Perché Firenze manda in tilt la logica della performance
- Il Presidente e la Madonna
- La nuova Strategia USA decisa da Trump, spiegata bene
- La Francia e il dibattito sulle radici cristiane d’Europa
 recent posts in English
recent posts in English
- Italy Prevails
- When Seeing Is No Longer Enough: Mantegna and the Silent Gaze of the Magi
- Fra Angelico and the Breaking Point of Beauty: Why Florence’s Exhibition Is Meant to Be Experienced, Not Just Seen
- God Is Back
- New York Turns the Tables: the “Socialist” Mayor Who Sounds (Almost) Like Trump
- Criticizing Israel Is not Antisemitism — and Heritage’s Kevin Roberts Just Said So
- Candace Owens: Polarizing Voice and Media Force in Contemporary American Conservatism
- Jeffrey Sachs: the Disenchanted Globalist
- Kremlin Shock: New Russian JFK Dossier Reveals Khrushchev's Disbelief and Suspicions of a U.S. Conspiracy
- When Silicon Valley Met the Occult: AI and the Return of Gnosticism
Archivi
cerca nel blog
categorie
Più cliccati
- Nessuno
Goodreads
-
Abbonati
Abbonato
Hai già un account WordPress.com? Accedi ora.